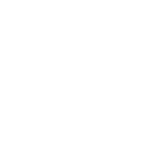La Cassazione, con l’ordinanza n. 31367 del 1° dicembre 2025, ha ribadito un principio chiaro: se l’ambiente di lavoro diventa fonte di stress e questo provoca un danno alla salute, il datore può essere chiamato a risarcire il lavoratore.
Non è necessario dimostrare un vero e proprio mobbing. Anche un singolo comportamento illecito, o il mantenimento di un clima lavorativo logorante, può integrare una violazione dell’art. 2087 c.c., che impone al datore di tutelare l’integrità psicofisica e la dignità del dipendente.
Quello che conta non è l’etichetta (mobbing, straining, burnot o altro), ma il risultato: se sono stati lesi diritti fondamentali come salute, dignità e identità personale, il danno va risarcito. La gravità o la ripetizione delle condotte incidono semmai sull’importo del risarcimento, non sull’esistenza del diritto.
Nel caso concreto, una lavoratrice aveva chiesto il risarcimento per danni alla salute derivanti dall’ambiente lavorativo. La Corte d’Appello aveva escluso il mobbing e il nesso causale. La Cassazione, però, ha chiarito che l’assenza di un intento persecutorio non basta a escludere la responsabilità del datore.
Sul piano probatorio, il lavoratore deve dimostrare il danno e il collegamento con l’ambiente di lavoro. Spetta invece al datore provare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire il pregiudizio, trattandosi di responsabilità contrattuale.
Conclusione: anche in un contesto di conflittualità diffusa, il datore resta responsabile se non tutela concretamente la salute del singolo lavoratore, specie in situazioni di particolare fragilità, come la gravidanza.