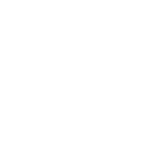Con la legge delega n. 144/2025 il legislatore compie una scelta chiara: archiviare, almeno per ora, l’ipotesi di un salario minimo fissato per legge e riportare al centro del sistema la contrattazione collettiva nazionale. L’obiettivo dichiarato è ambizioso e, sotto molti profili, condivisibile: garantire ai lavoratori una retribuzione proporzionata e sufficiente, come impone l’articolo 36 della Costituzione, contrastare il lavoro povero e il dumping contrattuale, stimolare il rinnovo dei contratti scaduti e arginare quelle forme di concorrenza sleale che si fondano sulla compressione del costo del lavoro e delle tutele.
La novità più significativa, però, sta nel criterio individuato per selezionare i contratti collettivi chiamati a svolgere questo ruolo di presidio costituzionale. La legge delega fa riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro “maggiormente applicati” per numero di imprese e di lavoratori, introducendo un parametro inedito rispetto al passato, che apre inevitabilmente nuovi interrogativi interpretativi e applicativi.
È bene ricordare che siamo di fronte a una legge delega. La disciplina concreta dovrà essere definita da decreti legislativi da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, quindi entro il 17 aprile 2026. Proprio in questi decreti si giocherà la partita più delicata, perché al Governo è affidato il compito di individuare, per ciascuna categoria di lavoratori, quali siano i CCNL maggiormente applicati e di stabilire che il trattamento economico complessivo minimo previsto da tali contratti costituisca la soglia economica minima da garantire ai lavoratori della stessa categoria, sempre nel rispetto dell’articolo 36 della Costituzione.
Questo passaggio segna una discontinuità rispetto all’impianto tradizionale. Fino ad oggi, infatti, l’individuazione del “contratto giusto” è ruotata attorno alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali stipulanti. Da un lato, per l’accesso alle agevolazioni contributive e normative, il riferimento è stato quello dei contratti sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Dall’altro, per la determinazione della base imponibile contributiva, il legislatore ha guardato ai contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. In entrambi i casi, il fulcro del sistema è sempre stato la qualità soggettiva delle parti firmatarie, pur in assenza, non va dimenticato, di un criterio normativo chiaro e definitivo di misurazione della rappresentatività sindacale.
La legge delega del 2025 sposta invece l’attenzione su un dato quantitativo: la diffusione effettiva del contratto nel tessuto produttivo. Ed è qui che sorgono le prime perplessità. A una lettura superficiale, si potrebbe arrivare alla conclusione che qualsiasi CCNL, anche con livelli retributivi modesti, possa diventare il parametro di riferimento minimo semplicemente perché applicato da un numero elevato di imprese e lavoratori. Una prospettiva che, se presa alla lettera, rischierebbe di svuotare di contenuto proprio quel principio di “retribuzione sufficiente” che la norma dichiara di voler tutelare.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, del resto, ha già chiarito che la contrattazione collettiva non è intangibile. Anche un CCNL sottoscritto da organizzazioni sindacali indiscutibilmente rappresentative può essere sindacato dal giudice se il trattamento economico previsto non rispetta i canoni dell’articolo 36 della Costituzione. In questi casi, il lavoratore ha diritto a ottenere un compenso equo, anche in deroga alle previsioni contrattuali. È un principio ormai consolidato, che funge da argine costituzionale contro ogni forma di sotto salario “contrattualizzato”.
A ben vedere, la legge delega sembra consapevole di questo rischio. Non a caso, la disposizione precisa che il trattamento economico minimo dei CCNL maggiormente applicati dovrà comunque essere coerente con l’articolo 36 della Costituzione. Questo lascia intendere che non ci si limiterà a una mera fotografia statistica dei contratti più diffusi, ma che sarà necessaria una valutazione di merito sui livelli retributivi effettivamente garantiti. In altri termini, la diffusione del contratto non dovrebbe essere sufficiente, da sola, a legittimarlo come parametro costituzionalmente adeguato.
Resta però un nodo cruciale, che la legge delega non scioglie: cosa accade se il CCNL maggiormente applicato in un determinato settore prevede trattamenti economici che non superano il vaglio dell’articolo 36? Quali strumenti correttivi verranno adottati? Si imporrà un adeguamento dei minimi contrattuali? Si individuerà un diverso contratto di riferimento? Oppure si lascerà ancora una volta al giudice il compito di colmare le lacune del sistema?
Sono domande tutt’altro che teoriche. Senza un parametro quantitativo chiaro e verificabile della “retribuzione giusta ed equa”, il rischio è quello di riprodurre le stesse incertezze che da decenni accompagnano il tema della rappresentatività sindacale. Il pericolo, concreto, è di muoversi in un terreno instabile, dove la certezza del diritto viene affidata più all’intervento giurisprudenziale che a regole chiare e preventive.
Come spesso accade nel diritto del lavoro, la vera portata della riforma dipenderà dai decreti attuativi. Sarà lì che si capirà se il richiamo ai CCNL maggiormente applicati diventerà uno strumento efficace per contrastare il lavoro povero o se, al contrario, rischierà di trasformarsi in un nuovo elemento di ambiguità, destinato a generare contenzioso anziché tutela. Da giuristi del lavoro, non resta che attendere, con attenzione critica, le scelte che il Governo compirà nel dare concreta attuazione a una delega che, nelle intenzioni, vuole rafforzare la centralità della contrattazione collettiva, ma che richiede un equilibrio delicato tra quantità e qualità delle tutele.