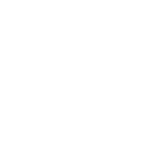Una piccola impresa non può più nascondersi dietro il tetto massimo di 6 mensilità per risarcire un lavoratore licenziato ingiustamente. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 118 del 2025, dichiarando incostituzionale quanto previsto dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015. Secondo la Consulta, quel limite fisso, valido per tutti i casi e non superabile, impedisce ai giudici di valutare la reale gravità del licenziamento, la sofferenza subita dal lavoratore e, di conseguenza, di garantire un risarcimento davvero adeguato e dissuasivo.
La pronuncia riguarda le imprese cosiddette “sotto soglia”, cioè quelle che non raggiungono i requisiti dimensionali previsti dall’art. 18 della Legge n. 300/1970: non più di 15 dipendenti per unità produttiva o Comune, e comunque non oltre 60 in totale. Per questi datori di lavoro, l’indennizzo previsto in caso di licenziamento ingiustificato – secondo il Jobs Act – non poteva superare le 6 mensilità, indipendentemente dall’anzianità del lavoratore o dalla gravità della violazione. Da oggi non è più così.
Per capire come cambia la disciplina, va considerata anche la data di assunzione del dipendente. Chi è stato assunto prima del 7 marzo 2015, se lavorava in un’impresa sopra soglia, era tutelato dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori; se lavorava in un’azienda più piccola, si applicava invece l’art. 8 della Legge n. 604/1966, che prevedeva un’indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità, aumentabile fino a 14 in caso di lunga anzianità.
Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi, la disciplina è invece quella del D.Lgs. n. 23/2015. In caso di licenziamento discriminatorio, nullo o orale, l’art. 2 prevede la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre a un’indennità minima di 5 mensilità e alla contribuzione previdenziale. Il lavoratore può scegliere di rinunciare alla reintegrazione e ottenere un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità, non soggetta a contribuzione, purché lo comunichi entro 30 giorni.
Nei casi in cui il licenziamento sia ingiustificato per insussistenza del fatto contestato, il giudice può disporre una “reintegrazione attenuata” e un risarcimento entro il limite di 12 mensilità. Quando invece il recesso è privo dei requisiti previsti (giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo), l’indennizzo può variare tra 12 e 24 mensilità, secondo quanto stabilito dall’art. 3. In presenza di sole violazioni procedurali, l’art. 4 prevede un’indennità tra 6 e 12 mensilità.
Nel caso delle piccole imprese, l’art. 9 del D.Lgs. 23/2015 applicava lo stesso sistema delle aziende più grandi, ma con due grosse differenze: l’indennità era dimezzata e la reintegrazione esclusa in molti casi. In concreto, il lavoratore riceveva una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità in caso di licenziamento ingiustificato; e, se si trattava di violazioni solo formali o procedurali (come quelle previste dall’art. 2, comma 2, della Legge n. 604/1966 o dall’art. 7 della Legge n. 300/1970), l’indennizzo scendeva a mezza mensilità per anno, tra 1 e 6 mensilità totali. Anche la reintegrazione era limitata ai soli casi di licenziamento discriminatorio, nullo, orale o legato alla disabilità del lavoratore.
La Corte ha bocciato questo sistema, giudicando incostituzionale il fatto che un lavoratore illegittimamente licenziato potesse vedersi riconoscere un indennizzo così basso, senza che il giudice potesse tener conto della gravità del recesso o delle circostanze concrete. Un sistema del genere non tutela in modo adeguato il diritto del lavoratore, né scoraggia il datore di lavoro dal licenziare ingiustamente.
Infine, la Corte ha rivolto un chiaro invito al legislatore: rivedere l’intera disciplina del licenziamento nelle micro e piccole imprese, superando l’eccessiva rigidità del criterio numerico e tenendo conto della reale forza economica dell’azienda. Perché non sempre un numero ridotto di dipendenti significa meno possibilità di sostenere i costi di una sanzione equa e proporzionata.